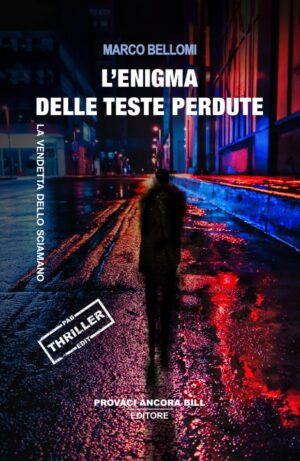
Un thriller colto che parla di Arte performativa per indagare il Male
Intervista all’autore del libro edito da Provaci ancora Bill Editore
Marco Bellomi – classe 1965 di professione bancario – ha una passione smodata per l’Arte e le esposizioni d’arte di cui è stato anche curatore.
Dalle arti visive passa alla passione per la scrittura, prima attraverso testi critici sull’arte poi scrivendo due romanzi. Adora le Wunderkammer, le Scienze d’altri tempi, le atmosfere dark e vittoriane, la musica underground.

Incontro Marco Bellomi presso la libreria Incipit23 di Milano in occasione della presentazione del suo ultimo nato “L’enigma delle teste perdute” edito da Provaci Ancora Bill Editore (2024). Una cosa va detta, a favore dei lettori: conosco Marco da quasi dieci anni, da quando ci incontrammo nel 2016 in un evento in ricordo di David Bowie.
Lucy Lo Russo per Punto e Linea Magazine: Hai appena dato alle stampe “L’enigma delle teste perdute” per Provaci Ancora Bill Editore. In che maniera questo romanzo si collega col tuo primo titolo?
Marco Bellomi: Il collegamento è molto forte. Nel primo romanzo, “Uno sciamano nel borgo” per Porto Seguro Editore emergeva la figura di un artista contemporaneo mongolo da poco trasferitosi in Italia, tra Liguria e Lombardia. Ecclettico e visionario, creativo ma anche profondo conoscitore degli stati alterati di coscienza indotti da piante officinali tradizionali, come un autentico sciamano. Al culmine della sua carriera artistica viene coinvolto in una vicenda che gli sfugge di mano trasformandolo in un’artista omicida. Attorno a lui, graviteranno ricchi collezionisti fobici, curatori e giornalisti problematici, donne dal passato irrisolto e ovviamente opere d’arte anomale e macabre, ma collezionate e contese da ricchi mecenati.
Nel sequel appena pubblicato, si riparte dagli ultimi avvenimenti narrati nel primo romanzo, in un crescendo di colpi di scena, descrizioni di operazioni chirurgiche dal sapore vittoriano e antico, pietrificazione di corpi umani e tassidermia d’antan, ma anche incursioni nel mondo dei social media pubblici e le storture che si portano appresso.
Il timbro, il filo rosso comune che unisce i due lavori, sono inevitabilmente le immancabili, grevi e fantomatiche “teste perdute”.
Lucy Lo Russo: Come mai hai voluto affrontare il tema del Male?
Marco Bellomi: ll concetto di Male è una delle tematiche centrali della letteratura e della filosofia, poiché coinvolge questioni morali, esistenziali e sociali. Nel mio romanzo il Male assume diverse forme e sfaccettature, manifestandosi sia a livello individuale che collettivo. Il titolo stesso dell’opera, suggerisce immediatamente un legame con il Male, poiché evoca immagini di brutalità e di enigmi irrisolti.
Il romanzo si sviluppa attorno a un’indagine su una serie di omicidi efferati nel campo dell’arte e del business art system, ma la violenza con cui questi crimini vengono perpetrati non è solo un mezzo per terrorizzare la società, ma anche una rappresentazione del Male in forma pura e primitiva direi quasi estetica. La brutalità dei delitti non è fine a sé stessa, ma riflette un sistema corrotto e perverso, in cui il confine tra giustizia e ingiustizia diventa sempre più labile.
Lucy Lo Russo: Quale pensi sia uno degli aspetti più interessanti dell’opera?
Marco Bellomi: Uno degli aspetti più interessanti dell’opera, credo sia il modo in cui costruisco i personaggi, rendendoli specchi di diverse sfaccettature del Male. L’assassino-artista non è un semplice carnefice, ma una figura complessa, il cui comportamento è il risultato di traumi, ossessioni e, forse, di una visione distorta della realtà. Non è un caso che ad un certo punto del romanzo, il protagonista non potendo più manifestarsi pubblicamente come artista pubblico e famoso, escogita di interpretare il ruolo di un misterioso Minotauro, epica figura metà uomo metà animale, ovvero un incrocio tra razionalità e follia selvatica.
La provocazione che suggerisco non è solo una questione letteraria, ma un invito ad esaminare con occhio critico il nostro rapporto con il macabro e l’arte.
Lucy Lo Russo: A cosa ti riferisci?
Marco Bellomi: Già nel 1827, Thomas De Quincey, con il suo saggio Delitto come una delle Belle Arti, sviluppa un’analisi singolare e provocatoria che si pone al confine tra estetica, ironia e riflessione sulla moralità: l’opera non è semplicemente una giustificazione dell’atto omicida, ma un esperimento letterario e filosofico che invita a considerare il crimine attraverso una lente inusuale come quella dell’arte, immaginando un contesto ipotetico in cui l’omicidio viene trattato come un’arte visiva o performativa, una disciplina che, come la pittura o la musica, può essere valutata secondo criteri estetici.
Lucy Lo Russo: Beh, direi una visione molto moderna! C’è qualche personaggio che apprezzi artisticamente che ti ha ispirato per le ambientazioni o per creare delle atmosfere?
Marco Bellomi: Direi più di uno, anche perché costituiscono il fulcro latente e sottotraccia di tutto il dispiegarsi del romanzo.
Partirei dal più volte citato ed evocato Paolo Gorini: matematico e scienziato italiano vissuto nella prima metà dell’Ottocento noto soprattutto come preparatore di cadaveri e parti anatomiche secondo un procedimento segreto da lui stesso inventato e sperimentato. Il suo operato fu apprezzato in Italia e all’estero in un momento storico in cui la medicina e la scienza in genere progredirono molto, grazie all’impulso e alla portata culturale del Positivismo. Nel romanzo è evocato spesso non solo per i processi imitati da Tuva [ndr. il personaggio principale della saga] ma per le atmosfere dark e gotiche che aleggiano attorno alla sua figura.
Lucy Lo Russo: Wow! Interessante, so già a chi potrebbe piacere questo thriller…

Marco Belloni: Poi il mio background di appassionato d’arte è espresso mettendo in luce diversi artisti visivi che nei loro lavori richiamano il tema delle teste decapitate.
Tralasciando l’immane lavoro artistico prodotto sul tema della decapitazione che ha attraversato secoli di storia dell’arte, assumendo significati diversi a seconda del contesto culturale, religioso e politico, è proprio con l’avvento della modernità che la decapitazione nell’arte perde il suo legame esclusivamente religioso o storico e inizia a essere interpretata in chiave più concettuale. Non si tratta più solo di rappresentare episodi biblici o eventi storici, ma di utilizzare la testa mozzata come metafora della perdita di identità, della violenza della società moderna o della frattura tra corpo e mente.
In questo senso tra gli autori che mi hanno, diciamo ispirato, allora troviamo senz’altro artisti come Francis Bacon e Marc Quinn che hanno reinterpretato questo tema in chiave esistenziale, esplorando il corpo umano come luogo di trasformazione, disfacimento e vulnerabilità. Sia Bacon che Quinn usano l’immagine della testa separata dal corpo per indagare il rapporto tra identità e mortalità. Se in Bacon il volto si sfalda in una visione esistenziale di angoscia e disfacimento, in Quinn la testa mozzata si trasforma in un inquietante monumento alla transitorietà dell’essere umano.
Queste opere dimostrano come la decapitazione, un tempo simbolo di violenza e punizione, sia diventata nell’arte contemporanea un potente strumento di esplorazione psicologica e filosofica, capace di evocare il senso di perdita, il cambiamento e la fragilità della condizione umana.
Lucy Lo Russo: Francis Bacon è un “colosso” e di Marc Quinn ricordo ai lettori l’opera “Self” (una scultura della sua testa fatta con il suo stesso sangue congelato). Anche qualcun altro?
Marco Bellomi: Altra citazione che mi sentirei di fare è la figura dell’artista Ron Athey. Uno degli artisti performativi più radicali e discussi degli ultimi decenni, la sua arte si basa sull’uso del corpo come medium primario per esplorare temi come il trauma, la spiritualità, l’identità sessuale e la malattia. Nato nel 1961 in California, Athey ha vissuto una serie di esperienze traumatiche che hanno profondamente influenzato la sua poetica. La sua pratica artistica, fortemente legata dalla contro-cultura queer e dal suo status di uomo sieropositivo, si caratterizza per l’utilizzo di tecniche estreme, come il piercing, il taglio e la manipolazione del sangue, che mettono in discussione il rapporto tra il pubblico e il performer, tra il sacro e il profano.
Non ultimo, forse la citazione più evidente ed importante: David Bowie
Lucy Lo Russo: Eccoci!
Marco Bellomi: Sì, uno degli artisti più poliedrici e visionari del XX secolo, capace di attingere a un vasto repertorio di miti, simboli e archetipi per dare forma alla sua arte. David Bowie ha sempre esplorato i lati più oscuri della psiche umana, e l’album 1. Outside (1995) rappresenta forse uno dei momenti più profondi e complessi della sua riflessione sul Male. Quest’opera fonde rock industriale, art rock ed elettronica in un concept album che esplora il crimine, la decadenza e la follia in un futuro distopico.
Lucy Lo Russo: Adoro 1. Outside di David Bowie. Ho scoperto che “risuona” molto bene in un pubblico giovane che magari non conosce il Bowie dei primi album…
Marco Bellomi: Certo! Non ne dubito. È costruito come un diario frammentario di Nathan Adler, un detective dell’arte che indaga su un macabro “omicidio rituale” in un 1999 oscuro e alienante. Qui il Male non è solo un atto criminale, ma un concetto fluido che si intreccia con l’arte, la società e la tecnologia. Bowie non presenta il Male in termini semplicistici, ma lo esplora come un’energia che permea il mondo postmoderno, dove la violenza diventa spettacolo e l’identità si frantuma in mille sfaccettature. L’album è una sorta di viaggio nelle ombre della condizione umana, un’opera ancora attuale che ci invita a riflettere su quanto il Male sia parte integrante del nostro tempo e della nostra identità. Mi sembrava troppo affine al concept del mio romanzo.
Lucy Lo Russo: Qual è la cosa che ti ha creato maggiori difficoltà nella narrazione?
Marco Bellomi: Credo che la difficoltà maggiore si è trasformata anche nel punto di forza del processo di scrittura. Ho passato diversi momenti ad approfondire argomenti, strutture, dati e processi scientifici facendo ricerche su testi e nel web. Devo dire che questo aspetto solitamente non mi intimorisce più di tanto o non rallenta il flusso creativo perché adoro scoprire ed imparare nozioni sempre nuove e stimolanti. Invero mi sono dovuto misurare con la complicazione del mantenimento della suspense, dell’interesse della storia tenendo conto che sono al secondo romanzo, sebbene sia da anni che mi misuro con la scrittura e l’arte.
Lucy Lo Russo: Come affronti la cosiddetta “pagina bianca”?
Marco Bellomi: Da parte mia credo che il cosiddetto trauma da “pagina bianca” sia un falso mito. Il mio metodo e processo di scrittura, sebbene relativamente acerbo, sia connaturato con un certo flusso di coscienza che mi viene spontaneo. Parto da una trama generica, non meglio dettagliata ma è proprio quando sono di fronte alla pagina vuota che spontaneamente e naturalmente riempio gli spazi vuoti con speditezza e ritmo che mi serve a dettagliare una narrazione a me ideale.
Lucy Lo Russo: Intendi ancora organizzare mostre o eseguire tu stesso opere come hai fatto per diverso tempo?
Marco Bellomi: Per ora non ci penso. Continuo a scrivere d’Arte nel mio blog “Rossodicadmio” e tento di inserirla nei miei romanzi.
Lucy Lo Russo: Grazie Marco, ti auguro il meglio per questo libro e il precedente. Mi ha fatto piacere questa chiaccherata, conoscere cose che non sapevo, o ripensare a opere d’arte viste in mostre.
Marco Bellomi: Grazie a te per la qualità delle domande he mi hanno permesso di poter focalizzare meglio alcuni argomenti a me congeniali.
PER SAPERNE DI PIÙ’:
Provaci Ancora Bill Editore
Blog Rossodicadmio
Wunderkammer/Camera delle Meraviglie


